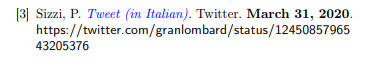Ripropongo un articolo in bergamasco che scrissi anni fa, in cui giustificavo l’uso del fiorentino emendato (l’italiano standard) per motivi essenzialmente di comprensione (altrui) e di praticità, nell’ipotesi di dover gestire uno spazio utilizzando solo il vernacolo orobico parlato dal sottoscritto (che ovviamente, essendo della provincia di Bergamo – metà scalvino e metà dell’Isola – non usa esattamente il bergamasco cittadino, sebbene nello scritto sia solito utilizzare, per convenienza, l’ortografia corrente del Ducato di Piazza Pontida).
Lo ripresento senza traduzione, perché comunque i locutori lombardi (cioè “gallo-italici”) non avranno alcun problema ad intenderlo. Il contenuto è un po’ duro e scabro e risente dei toni dell’epoca, ma il succo è sempre valido e più che mai attuale. La questione linguistica, in ottica lombardista, è fondamentale e la affronto con lo stesso piglio degli esordi: la Lombardia ha bisogno di una propria lingua nazionale, che in nessun modo può essere la lingua letteraria di Firenze (le cui radici filologiche affondano nel siciliano aulico medievale); il toscano, in Lombardia, è idioma straniero e la soluzione più razionale è promuovere il milanese classico volgare al rango di lombardo, accanto alla tutela degli idiomi locali.
L’italiano va gradualmente abbandonato de-italianizzando (ossia de-toscanizzando) la Lombardia. Assurdo e suicida che una terra romanza occidentale, prossima a quella galloromanza per antonomasia (la transalpina), accetti una lingua romanza orientale imposta da una esigua minoranza: il lombardo (col retoromanzo) è parente stretto di occitano, arpitano, francese (e catalano), mica dell’italoromanzo peninsulare. Avremo modo di riparlarne approfonditamente. Particolare è il caso veneto, ma se consideriamo che la “lingua veneta” non è altro che veneziano esteso ad una terraferma storicamente lombarda, caratterizzata da sostrato celtico e superstrato germanico (longobardo), non avrebbe senso escludere il cosiddetto Triveneto dal novero grande-lombardo, anche linguisticamente.
È noto che, nel Medioevo, Verona, Trento, Padova, Vicenza, Treviso (per non parlare della Transpadana ferrarese) fossero parte del continuum “gallo-italico” (soprattutto le prime due), spezzato dal dominio della Serenissima, e che esistesse addirittura una koinè lombardo-veneta, o meglio, lombarda e basta. Dante, nel De vulgari eloquentia, accosta la loquela di Brescia a quelle del Veneto continentale facendo intendere che avessero diversi tratti in comune. Anche il pavano di Ruzzante, il padovano rustico, si distingueva, in senso conservativo, dall’attuale loquela veneta. Del resto, Celti e Longobardi si stanziarono anche nella (Grande) Lombardia orientale – senza dimenticare il dominio visconteo esteso alle terre euganee – e lo stesso retoromanzo presenta un aspetto che, un tempo, doveva accomunare tutte le parlate padano-alpine.
Comunque sia, si pone anche una questione ortografica, risolta in parte dalla codificazione secentesca del milanese classico volgare; il compromesso tra grafia francese e toscana è sicuramente migliore delle astruserie contemporanee (stile Beretta o, appunto, Ducato di Piazza Pontida, ente folcloristico bergamasco), ma bisognerebbe studiare un sistema schiettamente lombardo, in linea col romanzo occidentale. Per quanto mi riguarda, rigetto ogni forma di esperanto, di koinè creata a tavolino oggigiorno e di imbastardimento toscaneggiante atto a rendere comprensibile agli italofoni non lombardi le nostre loquele, riducendole alla stregua di innocuo folclore da sagra della polenta.
Allo stesso modo rifiuto i goffi tentativi di plasmare pseudo-dialetti sovraprovinciali: per capirsi, bergamasco e bresciano sono idiomi transabduani molto affini ma con diversi elementi loro peculiari; se qualcuno crede che io possa mettermi ad usare un improbabile “lombardo orientale”, modellato sul bresciano, si è scolato il cervello, anche perché il prestigio storico, culturale e letterario della lingua di Bergamo, con tutto il rispetto per quella di Brescia, non ha paragoni nel resto della cosiddetta Orobia allargata (regione storicamente inesistente, oltretutto).
L’articolo che espongo qui sotto è reso con l’ortografia bergamasca moderna, che è poi l’unica in circolazione, utile per dare una sistemazione al bergamasco scritto. Ma, si capisce, andrebbe completamente rivista e basata, piuttosto, sull’ortografia classica meneghina. L’alluvione di accenti gravi e acuti (peraltro errati laddove si tratti di i e di u, accentate alla toscana), la sciocca Umlaut per rendere il suono turbato di o e u, le elisioni inesistenti e altre baggianate pensate appositamente per costringere il bergamasco nel letto di Procuste dell’italiano contribuiscono a ghettizzare la nostra lingua locale, rendendola illeggibile, “ostrogota” e parodistica. Un idioma lombardo va inquadrato in lombardo, non in toscano. Più avanti avrò modo di esporre le mie proposte di orobico emendato, per adesso portate pazienza.
Ergü a l’ pödrèss domandàs che manéra mé, che dighe de defènd identidà, tradissiù, e quinde lèngua, a scrìe mia zó in lombàrd, in bergamàsch, ma ‘n taià, in fiurentì netàt. A l’è öna quistiù resunada e sàa.
Pröm de töt, gh’è de dì che te’ sö ü blògh in lèngua a l’è mia ü laùr de negót, de töcc i dé; a l’è öna bèla fadiga e mè èss bu, feràcc, e saì bé chèl che se scriv zó.
Ol rés-cc l’è chèl de scriv zó di stüpidade, de mes-cià sö i dialècc e, ‘n buna sostansa, de fà dét öna acada. Mè cognòssela bé la lèngua, prima de fà ü laùr dol zèner.
Mé dróe mia, de sòlet, ol bergamàsch de la sità, chèl clàssech, a dróe chèl de l’Ìsola, a sira de Bèrghem, fò d’ sura con dét öna quach scalvinada perchè mé pàder a l’éra de la Al.
Adèss, e sèmper quand che scrìe zó, sirche de droà ol bergamàsch clàssech, ma só bé che ergót de “cuntadì” a l’ me sgula fò de sigür.
A l’è ixé zùegn, a l’è tròp malfà tègn sö ü blògh in lèngua dol lögh perchè só mia de Bèrghem sità, parle ol dialèt bergamàsch dol Brèmb, disém, con di ótre inflüènse oròbeghe, e pò dòpo gh’è ach de dì che ol bergamàsch, compàgn de töcc i óter dialècc dol lombàrd, a l’ gh’arèss de bisògn de èss netàt, de fal deentà bèl ladì e desliberàl de töcc is-ce sacranòn’ de assèncc e di sporselade toscane e forèste.
Ma ol laùr piö malfà a l’è la zét che la me lès: quace i è chèi che i ghe rierèss a stam dré, a capì chèl che cönte sö e che scrìe zó, e a discüt? Zamò a i è póche i bergamàsch, figürémsem i óter lombàrcc. E i forestér?
Ché a s’ parla mia di mé bale de töcc i dé, baie sö laùr piö malfà e nessessare che la mé éta nüda e crüna.
E alura sirchém de fas capì de töcc, pò aca de chèi che i è mia lombàrcc, per pèrdei mia per istrada. Se de nò i cambierèss inderéss.
Ma a gh’è ön óter laùr: ol lombàrd prénsep a l’è ol milanés, mia ol bergamàsch, e chèl dialèt lé a l’ gh’arèss de deentà ol lombàrd, la lèngua lombarda öfessàla de töta la Lombardéa Granda e dol sò Stat.
Se a cognossès bé ol meneghì a pödrèss pensaga, de te’ ‘n pé ü blògh in lombàrd, ma l’è mia ixé e l’è mèi che a scriv zó ‘n milanés, per adèss, a i ghe pènse chì de Milà (sèmper ch’ i sìes amò iv, a s’ capéss). Se mia pròpe pròpe de Milà almànch de chèle bande lé (‘Nsübria).
Scrìe zó chèl artìcol ché ‘n bergamàsch per faga capì a töcc che a l’ mastèghe bé (a la mé cà a s’ dróa adóma oròbech), e perchè scriv zó negót negót in lèngua, söl mé “diare” ché, a l’ sarèss pròpe mia ol màssem; ma ad ògne mód sigheteró a scriv zó ‘n toscà (taià) con buna pas de la mé lèngua màder (che però, a l’ siès ciar, baie sö, defènde, protèse e só orgoiùs de iga ‘n dol sangh, fröt dol caràter e de la rassa de la mé zét).
E alura droém chèst pòta de taià (fiurentì leterare), la lèngua dol “nemìs”, che però a m’ cognòss töcc quancc, e che la aìda ‘n de cümünicassiù e ‘n de la batàia identidaria. Fém mia i ganasse quand che gh’è de mès i resù de la nassiù lombarda, s-cècc.
A l’è mia ötel seràs sö e teà i pucc col rèst dol mónd; adèss a m’ gh’à amò de iga a che fà co’ la Tàia, tatsichè mè per fórsa droà la sò lèngua per fà frötà i nòste sömésse cültürài e polìteghe. A l’ dighe mia adóma per mé, ma aca per ol MNL, i lombardés-cc e chèi ch’ i völ tecàs con nóter, per combàt cóntra ol töt insèma.
E ardì che mè partì pròpe de chì laurzì ché compàgn di blògh, di fòrüm, di récc sossài a la Léber di müs e compagnéa bèla, prima de rià a parlà de moimécc e partìcc. Chèst sö la rét a l’è ü bèl cap de adestramét.
Fat istà che i mé blògh a i è sèmper stàcc scriìcc zó in taià, se de nò nigü o gran póche persune i me sarèss stace dré, zét adóma de Bèrghem e d’öna sèrta età; che pò dòpo a l’è piö probàbel che chèi ch’ i parla e capéss ol bergamàsch, ma bé bé, sö la rét a i ghe sìes gnach, e magare i gh’à gnach ol compütadùr (o ‘l telefunì). A só dré a parlà di ècc, a se capéss.
I zùegn ol dialèt i la parla mia, o fòrse fòrse i böta dét öna quach parulina, o parolassa; a l’ manca ol bassì de letùr ch’ i parla lombàrd sö l’uèb, per adèss, e alura negóta sbrofade.
L’istèss resunamét me l’ fà pör cume Moimét Nassiunalést Lombàrd; per ol momènt se dróa ol toscà, ‘n de propaganda e ‘n de dutrina, ma a m’ sircherà pò ach de lauraga dré al milanés per fal deentà, cume ó dìcc piö sura, la lèngua di lombàrcc, ol lombàrd.
‘N che manéra? Vocabolare, gramàteghe, fonétega, ortograféa, töte ròbe de sgürà vià per bé perchè ol meneghì clàssech, chèl dol Mas e dol Pórta, ach se l’è orisinàl, a l’ sà ön pó tròp de Fransa e de Toscana (e ol bergamàsch clàssech a l’ sà ü petì de Enéssia). Parlém mia de chèl növ nöènt che a l’ sènt pò de terunade!
A l’ vegnerèss fò pròpe ü gran bèl laurà ma a l’ ne alirèss la péna. Per di órghegn de stampa dol töt in lèngua, però, adèss l’è tròp prèst, i tép a i è amò zèrb.
A l’è mia öna contradissiù nè! Me recomande! A s’ gh’à de parlà de Bèrghem, de Oròbia, de Lombardéa, de Tàia (pörtròp), de Öròpa e dol mónd (amò pörtròp) per fórsa ‘n fiurentì, se de nò a l’ và töt a fas ciaà de chèl frà! A l’è cume pretènd de baössà de ‘ndependènsa quand che i lombàrcc i pènsa de èss taià, padà, svìsser, ‘strìech o magare sitadì dol mónd.
Nóter lombardés-cc a m’ völ fà i laùr per bé; chì óter, che pötòst de droà ol servèl i droa la bògia, i passerà per di Se Gheàra de quàter ghèi o di leghés-cc patacù ch’ i gh’à a cör adóma la famusa cadréga.
Ol discórs a l’ val ach per ol lombàrd: prima de la lèngua gh’è la rassa e la tèra, pus la cültüra, ma se ü a l’ fà l’ contrare a l’ se trà la sapa sö i pestane perchè cültüra sènsa sangh, sènsa rassa, sènsa identidà a l’è compàgn dol fé e de la aca sènsa ‘l malghés.
Ol mé sògn a l’è chèl de droà ‘n töta la Lombardéa ol milanés cume lèngua öfessala, e de fà alì i nòs-cc dialècc ‘n di nòs-cc cantù sènsa ‘mpestài sö e mes-ciài per faga dét chissà che sbrògia, e ‘nsèma a chès-ce laùr ché fa sparì de ‘ntùren ol toscà e töte i parlade forestére (e chèi ch’ i la baia sö).
Mè daga ü bèl pessadù a ‘l taià e ri-mandàghel zó ai “bìscher” e ai “terù” (aé ‘nsóma, ai taià), chè l’è la sò de lèngua, ol dialèt dol latì piö pür (pus dol sardagnöl, perchè fàcc sö adóma de itàlech).
Nóter a m’ sè mia taià nassìcc ‘n de la Tàia, maseràcc dol mar vòst; a m’ sè lombàrcc nassìcc in de la Lombardéa Granda, tra i Alp e ‘l Penì, Öròpa de mès (piö o manch), tèra di Gai e di Longobàrcc. Per vèss piö pressìs a m’ sè l’anèl che ‘l zónta ol Mès al Mesdé.
Ol toscà l’è bu per imbrombà sö ‘l có de sbambossade, cöntà sö bale e scóndega ol vira a la zét lombarda; ixé i la dróa chì de Róma e i sò slapa-pé.
Nóter nò, a m’ dróa ol toscà perchè uramài i la cognòss e parla ol gròss di lombàrcc, e pròpe per chèsta resù ché me l’ dróa per dì sö la erità ‘n mès ai nòs-cc fradèi, amìs, nemìs, invasùr: nu a m’ gh’à mia pura de trà fò la stòria netada de töt ol rüt che i taià i gh’à bötat sura per sotrà ol delbù, e guarida de töt ol tòssech spandìt dol triculùr in dol nòst sàcher söl.
Ol vira a l’ ghe fà mal ai zacuì, ai massù, ai précc dol dé de ‘ncö , ai fassés-cc növ e a chì cóntra, ai mafiùs, a töcc chèi che, ‘nsóma, i ghe maia sura i menade triculurade.
Ma chi l’è de la banda dol bé, dol giöst, de la natüra a l’ gh’à de iga pura de negót e de nigü perchè la sacra e santa erità dol sangh, de la tèra e dol ispéret a l’è ‘nsèma a lü e al sò pòpül.
Chèsta l’è la missiù, de portà ‘nàcc, per bèfa, a partì de la lèngua di ocüpàncc.
Scrivere con questo sistema ortografico moderno, ad uso e consumo dell’italocentrismo, è assai faticoso e anche la lettura diventa farraginosa ed estenuante. Le grammatiche bergamasche del Mora e dello Zanetti (così come il vocabolario del Tiraboschi) adottano tale folcloristico metodo, e per quanto siano lavori pregevoli – nell’ottica di dare una sistemazione univoca alla lingua di Bergamo – restano incoerenti (con la filogenesi del lombardo) e prostrati di fronte all’inesistente superiorità dell’italiano, per giunta inquadrato come lingua nazionale di una terra, la Lombardia, che non è in alcun modo italiana.